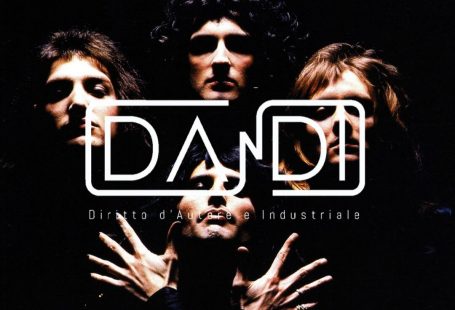Nel complesso mondo dei marchi, la protezione del vostro segno distintivo è fondamentale. Ma cosa succede quando un marchio simile al vostro compare sul mercato? Il diritto dei marchi si preoccupa principalmente di evitare che i consumatori siano ingannati. Per farlo, si concentra su due concetti chiave: il rischio di confusione e il rischio di associazione. Approfondiamo insieme queste distinzioni cruciali.
Cos’è il rischio di confusione nel diritto dei marchi?
Il rischio di confusione è il pilastro fondamentale della protezione del marchio. Si verifica quando il consumatore medio, a causa della somiglianza tra due marchi (o tra un marchio e un segno non registrato) e/o tra i prodotti o servizi che essi contraddistinguono, può credere erroneamente che i prodotti o servizi provengano dalla stessa impresa, o da imprese economicamente collegate.
- Esempio: Se un nuovo marchio di scarpe si chiama “Niky” e usa un logo molto simile a quello di “Nike”, c’è un alto rischio che i consumatori confondano le due aziende o pensino che “Niky” sia una linea secondaria di “Nike”.
Quali elementi vengono considerati per valutare il rischio di confusione?
La valutazione del rischio di confusione è un’analisi complessa che tiene conto di diversi fattori, valutati nel loro complesso e non singolarmente:
- Somiglianza tra i segni: Si analizza la somiglianza visiva (come appaiono), fonetica (come suonano) e concettuale (il significato o l’idea che evocano).
- Somiglianza tra i prodotti o servizi: Quanto sono simili i beni o servizi offerti dai due marchi? Più sono simili, maggiore è il rischio.
- Forza distintiva del marchio anteriore: Un marchio “forte” (ad esempio, un marchio di fantasia come “Kodak” per le macchine fotografiche, che non ha un significato preesistente per quel prodotto) gode di una protezione più ampia rispetto a un marchio “debole” (ad esempio, “Mela” per un fruttivendolo).
- Canali di distribuzione: Se i prodotti sono venduti negli stessi negozi o online, aumenta il rischio.
- Pubblico di riferimento: Chi sono i consumatori? Un pubblico specializzato potrebbe essere meno propenso alla confusione rispetto al consumatore medio.
Cos’è il rischio di associazione e in cosa si differenzia dal rischio di confusione?
Il rischio di associazione è un concetto più ampio e, per certi versi, più sottile del rischio di confusione. Si verifica quando il consumatore, pur non confondendo direttamente le due imprese, crede che esista un collegamento economico o organizzativo tra di esse. Non pensa che siano la stessa azienda, ma immagina che ci sia una partnership, una licenza, una sponsorizzazione o un qualche tipo di affiliazione.
- Esempio: Se un’azienda lancia un nuovo profumo chiamato “Chanel Nº 6” senza autorizzazione di Chanel, il consumatore potrebbe non pensare che sia un profumo di Chanel, ma potrebbe credere che sia un prodotto realizzato in collaborazione o sotto licenza con la famosa casa di moda.
La differenza chiave è nel grado di errore del consumatore:
- Confusione: “Sono la stessa cosa/azienda.”
- Associazione: “Non sono la stessa cosa, ma sono collegate in qualche modo.”
Perché il rischio di associazione è importante, specialmente per i marchi rinomati?
Il rischio di associazione è particolarmente rilevante per i marchi rinomati (o “notori”). Questi marchi godono di una protezione più ampia, che va oltre la semplice somiglianza dei prodotti o servizi. La loro notorietà può essere danneggiata anche da un uso di un segno simile per prodotti completamente diversi, se ciò crea un’associazione ingiustificata.
- Esempio: L’uso di un marchio “Ferrari per articoli di cancelleria potrebbe non confondere il consumatore sulla provenienza (nessuno penserebbe che Ferrari produce penne), ma potrebbe far credere che ci sia una licenza o un’approvazione da parte della casa automobilistica, diluendo così il prestigio del marchio Ferrari o sfruttandone indebitamente la reputazione.
Come si valuta il rischio di associazione?
La valutazione del rischio di associazione si basa su criteri simili a quelli del rischio di confusione, ma con un’enfasi maggiore sulla notorietà del marchio anteriore e sulla capacità del segno successivo di evocare o richiamare quel marchio, anche in assenza di una diretta sovrapposizione di prodotti. Si considera se il consumatore, vedendo il secondo marchio, sia portato a richiamare alla mente il primo, creando un collegamento mentale.
Qual è l’impatto di questi rischi sulla strategia di branding e registrazione?
Comprendere la differenza tra rischio di confusione e rischio di associazione è vitale per chiunque voglia registrare e proteggere un marchio:
- Ricerca di anteriorità: Una ricerca approfondita non deve solo individuare marchi identici o simili per prodotti identici o simili (rischio di confusione), ma anche marchi rinomati che, pur operando in settori diversi, potrebbero generare un rischio di associazione.
- Strategia di difesa: In caso di controversia, la strategia legale dipenderà dal tipo di rischio che si intende dimostrare. Per i marchi rinomati, la prova del rischio di associazione può essere sufficiente per ottenere protezione.
- Innovazione: Le aziende che sviluppano nuovi marchi devono essere consapevoli che anche una somiglianza concettuale o una semplice evocazione di un marchio noto può portare a problemi legali.
In conclusione, la protezione del marchio non è solo una questione di evitare la “copia”, ma anche di prevenire la “suggestione”. Sia il rischio di confusione che il rischio di associazione sono strumenti essenziali per garantire che i marchi mantengano la loro funzione distintiva e che i consumatori non siano mai tratti in inganno.
Con 4 sentenze, la Corte di giustizia ha definito il rischio di confusione e successivamente ha dovuto pronunciarsi su diversi aspetti che richiedevano chiarimenti in riferimento all’ipotesi di marchi identici o simili, o anche prodotti identici o simili coperti da tali marchi.
Si tratta delle sentenze:
- Puma/Sabel dell’11 novembre 1997,
- Canon/Metro Goldwin del 29 settembre 1998,
- Lloyd Schuhfabrik Meyer/Klijsen del 22 giugno 1999 e
- Adidas/Marca Mode del 22 giugno 2000.
In una quinta sentenza, Medion/Thomson del 6 ottobre 2005, la Corte ha ripreso e confermato tutti i principi precedentemente stabiliti.

La sentenza Sabel/Puma
Enuncia il seguente concetto: la semplice associazione tra due marchi che potrebbe essere stabilita dal pubblico in ragione del loro contenuto semantico coincidente non è sufficiente, in sé, per concludere che esista un rischio di confusione.
Tale insegnamento è confermato dalla sentenza Canon/Metro Goldwin.
La Corte si è basata sia sul testo dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sia sul decimo ‘considerando’ della direttiva per spiegare che la nozione di “rischio di associazione” non rappresenta un’alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serve a definirne la portata. Il decimo ‘considerando’ precisa con chiarezza che il rischio di confusione costituisce la condizione della tutela.
Il rischio di confusione
Va notato altresì che, nella sentenza Puma, la CGCE ha optato per il principio della confusione senza però fornire una definizione positiva del concetto di “rischio di confusione comportante anche un rischio di associazione”, cosa che avrebbe fatto successivamente, nella sentenza Canon, circoscrivendolo come segue: il rischio di confusione va interpretato come il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro.
Vi si ravvisa la possibilità di un rischio diretto e indiretto:
- il primo riguarda il legame tra i marchi e i segni,
- il secondo quello tra i titolari dei marchi e dei segni.
Elaborazione del principio del rischio di confusione
Poiché il rischio di confusione è legato alla questione dei marchi somiglianti e dei prodotti somiglianti, analizziamo i diversi aspetti da chiarire nell’ottica di tale rischio, ossia
- la somiglianza tra i segni,
- la somiglianza tra i prodotti o servizi,
- le modalità di valutazione del rischio di confusione e
- il pubblico per il quale occorre valutarlo.
Come procedere alla valutazione?
Nel caso Puma/Sabel, la Corte tedesca che ha interpellato in via pregiudiziale la CGCE doveva pronunciarsi in merito alla questione se un contenuto semantico coincidente dei marchi fosse sufficiente per concludere che esisteva un rischio di confusione. Orbene, non è sufficiente.
La risposta della Corte è stata chiara: occorre valutarlo
globalmente, tenendo presenti tutti i fattori pertinenti della fattispecie, e segnatamente la notorietà del marchio sul mercato, l’associazione che può essere stabilita con il segno utilizzato o registrato e il grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati (sentenza Puma).
Inoltre, globalmente significa che la somiglianza visiva, uditiva o concettuale deve essere fondata sull’impressione complessiva prodotta dai marchi tenendo presenti, in particolare, gli elementi distintivi e dominanti del marchio.
Per quale motivo occorre valutarlo globalmente?
Perché il consumatore medio percepisce un marchio con un’entità unitaria e non effettua analisi.
Di quale consumatore si tratta?
Si tratta del consumatore medio del tipo di prodotti specificamente in questione. Va peraltro rilevato che, nell’approccio globale, un elemento di somiglianza (per esempio, auditiva) può essere neutralizzato da dissomiglianze visive e/o concettuali (sentenza Ruiz‐ Picasso del 12 gennaio 2006). La Corte ha avuto occasione di rammentare l’importanza dell’applicazione dell’approccio globale in riferimento al caso di un marchio complesso di tipo visivo che contiene un elemento dominante: solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili, la valutazione della somiglianza può avvenire unicamente sulla base dell’elemento dominante (sentenza Shaker del 12 giugno 2007 – marchio limonchello).
Sentenza Medion
Nelle circostanze molto particolari della sentenza Medion del 6 ottobre 2005 (marchi Thomson – Life Thomson), la Corte doveva esprimersi sul caso in cui un marchio anteriore complesso, che contiene la denominazione dell’impresa, mantiene una posizione distintiva autonoma, pur senza costituirne l’elemento dominante. Nella fattispecie, l’impressione complessiva prodotta dal segno composto può indurre il pubblico a credere che i prodotti o servizi provengano perlomeno da imprese economicamente legate tra loro.
La Corte ha ammesso
che può sussistere un rischio di confusione per il pubblico, in caso di identità dei prodotti o dei servizi, quando il segno controverso è costituito dalla giustapposizione, da un lato, della denominazione dell’impresa del terzo e, dall’altro, del marchio registrato, dotato di normale capacità distintiva, e quando quest’ultimo, pur senza determinare da solo l’impressione complessiva del segno composto, conserva nell’ambito dello stesso una posizione distintiva autonoma.
Lo Studio Legale Dandi fornisce assistenza legale in Proprietà intellettuale. Dai un'occhiata ai nostri servizi oppure contattaci!