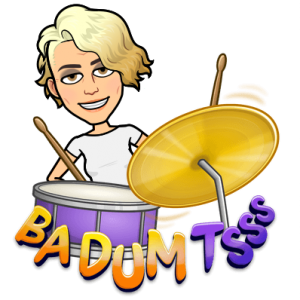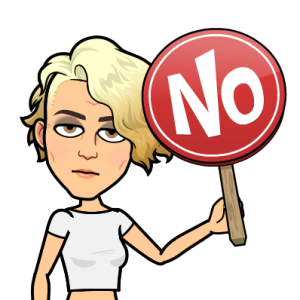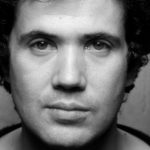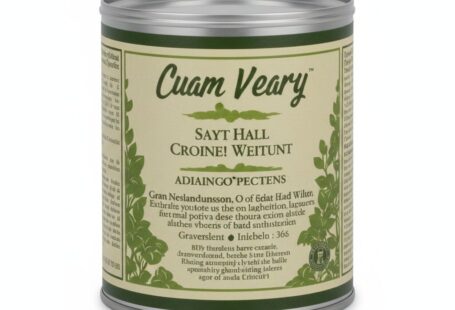Cosa sono le opere collettive?
Ti rispondo subito. Le opere collettive sono quelle opere dell’ingegno frutto del contributo creativo di più autori. Tipo? In legalese direi che le opere collettive sono costituite dalla riunione di opere o di parti di opere che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso politico ed artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali. Più facilmente direi che di solito sono opere letterarie, create dall’unione di lavori minori o frammenti di lavori di autori diversi, riuniti per uno scopo determinato, per lo più divulgativo, didattico o scientifico. Un esempio classico? Le enciclopedie. Un esempio moderno? Wikipedia. Un altro esempio? I giornali e le riviste.
La legge sul diritto d’autore tutela anche le opere collettive?
La risposta è …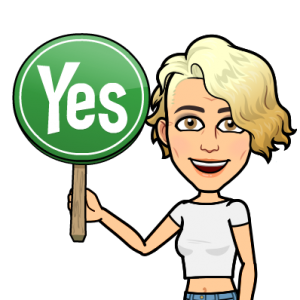
Sono tutelate dalla legge.
La legge sul diritto d’autore tutela anche le opere collettive in particolare:
- all’art. 3 che dice che Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte;
- all’art. 7 che dice che è considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa. E’ considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
- all’art. 38 che dice che nell’opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa, senza pregiudizio derivante dall’applicazione dell’art. 7. Ai singoli collaboratori dell’opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l’osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.
Riassumendo, nelle opere collettive:
- il diritto morale d’autore spetta a chi dirige e organizza l’opera complessiva,
- il diritto di utilizzazione economica dell’opera, nel suo complesso e in ciascuna delle sue parti, spetta all’editore, salvo patto contrario,
- il singolo collaboratore, in presenza di determinate condizioni, ha la facoltà di utilizzare la propria opera separatamente.
Perché un’opera possa essere tutelata come collettiva deve assumere connotati distinti e autonomi dalle singole parti che la compongono. Infatti è proprio l’art. 3 a dire che:
- le opere collettive […] sono protette come opere originali”,
- la tutela è conferita “indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte”. Ne consegue che la legittima utilizzazione dell’opera collettiva presuppone il consenso degli autori dei singoli contributi, che vengono coordinati e inseriti nell’opera collettiva.
Attenzione all’art. 11 – che riconosce agli enti privati il diritto di autore sulle pubblicazioni dagli stessi curate – letto insieme all’art. 3 – che fa salvi i diritti degli autori delle singole opere.
Nel caso di indebita pubblicazione di scritti tratti da opere collettive, l’autore di ciascuno scritto conserva il diritto di rivendicarne la paternità e di chiedere il risarcimento del danno arrecatogli.
Infatti il diritto di autore riconosciuto all’ente committente si affianca ma non sostituisce quello di colui che ha creato l’opera, e ciò indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica di quest’ultima ed anche dopo la cessione degli stessi. (Cass. civ. Sez. I Sent., 04/02/2016, n. 2197 (rv. 638582)).
Quali sono le opere collettive?
Come detto le opere collettive sono opere formate mediante l’unione di lavori o frammenti di lavori di autori diversi e riuniti da un coordinatore con un determinato scopo. Ne abbiamo già individuate alcune come le enciclopedie, le riviste, i giornali, le antologie e gli scritti di questo genere. Ma le opere collettive, in quanto composte dal contributo di numerosi autori, possono essere anche i cataloghi delle mostre.
Chi è l’autore del catalogo di una mostra? Beh l’autore è chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa, quindi il curatore della mostra o l’organizzatore.
Ovviamente al fine di individuare l’autore di un’opera collettiva vale la presunzione stabilita dall’art. 8. Questo articolo dice che è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa. La presunzione, in quanto tale, può essere superata dalla presenza di plurimi e concordanti elementi quali, ad esempio:
- le indicazioni non univoche presenti sull’opera, tali da creare ragionevoli dubbi sulla titolarità effettiva dell’opera;
- la concessione in esclusiva a un terzo, dietro corrispettivo, dei diritti sull’opera raccolte nell’opera compilativa.
Sempre in tema di diritti c’è da dire che la mancata concessione, ad una parte, dei diritti sulle singole opere contenuti in un’opera collettiva come, ad esempio un catalogo, è un elemento particolarmente significativo per escludere la titolarità dei diritti su un’opera collettiva, a favore invece del soggetto che tali diritti ha effettivamente acquisito. Lo stesso art. 3 sancisce che “le opere collettive […] sono protette come opere originali”, precisando che la tutela è conferita “indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte”, sicché la legittima utilizzazione dell’opera collettiva presuppone il consenso degli autori dei singoli contributi, che vengono coordinati e inseriti nell’opera collettiva.
Opere collettive e non: cosa tutela la legge sul diritto d’autore
Vediamo se sei attento. Abbiamo detto quali sono le opere collettive e che la legge sul diritto d’autore tutela le opere collettive. Ma secondo te un film o un musical sono opere collettive?
Rullo di tamburi…
Un film, come un musical, è un’opera composta. Le opere composte sono quelle che, anche se realizzate da più autori e utilizzabili separatamente, risultano come una creazione unica ed hanno una identità organica e meno “separabile”. Possono, infatti, essere suddivise in parti, ma tale suddivisione porta ad un risultato molto diverso dall’opera nel proprio complesso.
Come si suddividono i diritti d’autore nelle opere composte? Secondo i criteri di ripartizione tra gli autori delle singole parti. Per esempio, nel caso specifico delle opere musicali, quando si depositano presso la SIAE, si richiede la compilazione del cosiddetto “Modulo 112”. Nel modulo si possono indicare i nominativi degli autori con le rispettive quote di diritti (che si presumono ripartiti in parti eguali, ma che possono essere derogate in base agli accordi tra le parti.
Per complicarti la vita ti dirò che esistono anche le opere in comunione. Le opere in comunione sono quelle in cui il contributo di ciascun artista è indistinguibile ed inscindibile da quello degli altri. Un esempio? Un quadro dipinto a più mani. In questo caso valgono le regole generali del diritto civile sulla comunione e le azioni di difesa del diritto morale sono esercitabili individualmente da ciascun coautore.
Opere collettive: il Musical
Il Musical come opera composta protetta dal diritto d’autore. Il musical è un genere di rappresentazione teatrale e cinematografica, nato e sviluppatosi negli USA tra l’800 ed il ‘900.
Un suo corrispondente in Italia è la commedia musicale, con cui condivide l’uso di più tecniche espressive e comunicative insieme.
L’azione viene portata avanti sulla scena non solo dalla recitazione, ma anche dalla musica, dal canto e dalla danza che fluiscono in modo spontaneo e naturale.
Il musical è uno spettacolo derivato dall’opera e adattato al gusto e al costume statunitense. Questo spettacolo è costituito da una commedia, in genere brillante e di ambientazione americana nella quale sono presenti brani che appartengono ai generi della musica leggera, del jazz, o derivano dall’opera lirica e dal balletto. Tutti questi linguaggi sono uniti tra loro grazie a una orchestrazione elegante e perfetta. Nel musical non c’è fusione tra i diversi linguaggi; i diversi generi sono invece affiancati in una compresenza ben integrata e armonizzata.
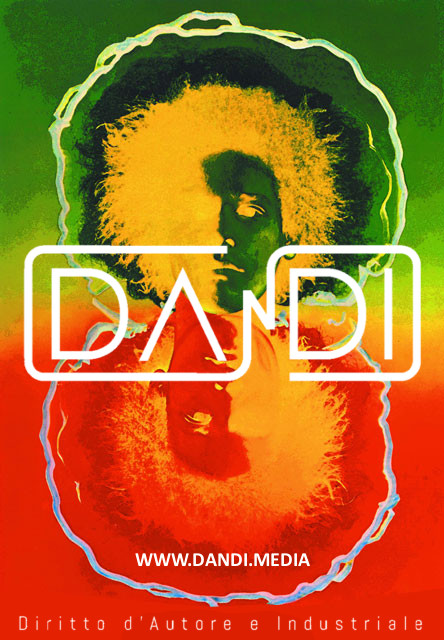
In questo genere ogni particolare risulta indispensabile per la riuscita dello spettacolo, dai costumi dalla scenografia includendo regia, coreografie e luci senza dimenticare gli attori (chiamati performers) che devono essere in grado di comunicare emozioni ricorrendo, spesso contemporaneamente, a discipline come la recitazione, la danza e il canto.
Il musical va, inoltre, attentamente distinto dal Teatro-danza: quest’ultimo, infatti, è fenomeno non solo più recente, propriamente novecentesco, ma concettualmente più avanzato e di maggiore complessità estetico-linguistica.
SIAE – Sezione teatro
Le opere teatrali (quali opere di prosa, produzioni per bambini, spettacoli di burattini e marionette, opere di cabaret, circo-teatro) e del teatro musicale (quali le operette, i musical, le commedie musicali) sono tutelate dalla sezione DOR (Opere Drammatiche e Radiotelevisive).
Il Musical come opera composta protetta dal diritto d’autore
Riguarda gli elaborati creati dall’unione di diverse categorie di opere (per esempio testi e musica).
Agli art. da 33 a 37 l.d.a. sono prese in considerazione le opere drammatico musicali con parole, le opere coreografiche e pantomimiche, che sono generalmente frutto della creazione intellettuale di più autori, e conosciute col termine “opere composte“.
Di tutte queste opere la legge non offre la definizione. Inoltre questa disposizione fissa il carattere dispositivo, e non imperativo, delle norme: le parti sono libere di regolare come vogliono, contrattualmente, i loro rapporti economici nella utilizzazione dei rispettivi diritti esclusivi.
L’art. 33 l.d.a. afferma che, in caso di mancanza di accordi tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, a balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli (34, 35, 36).
L’art. 33 l.d.a. si occupa di dare una regolamentazione generale alla materia, affermando che, in caso di mancanza di accordi tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, a balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.
Le parti sono libere di regolare come vogliono, contrattualmente, i loro rapporti economici nella utilizzazione dei rispettivi diritti esclusivi.
Autore della parte musicale
L’art 34 si occupa di regolare i rapporti tra autore della parte musicale e autore del testo nelle composizioni musicali con parole. In questo caso l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera spetta all’autore della parte musicale, e il relativo profitto viene ripartito in proporzione del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nei commi successivi l’art. 34 regola alcune categorie di opere musicali. Nel caso delle opere liriche, il valore della parte musicale rappresenta la frazione di tre quarti del valore complessivo dell’opera (terzo comma). Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale (quarto comma).
Infine ciascuno dei collaboratori ha il diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti (quinto comma).
Il diritto di utilizzazione economica spetta all’autore della parte musicale eccetto i diritti derivanti dalla comunione. Il profitto di utilizzazione economica viene ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
Alcuni tipi di opere musicali:
- Opere liriche: si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell’opera.
- Operette, melologhi, composizioni musicali con parole, balli e balletti musicali; i contributi hanno lo stesso valore.
I collaboratori hanno il diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera (art. 34 comma 5).
Autore della parte letteraria
Secondo l’art. 35, l’autore della parte letteraria non può disporre di questa, per congiungerla ad altro testo musicale, al di fuori dei seguenti casi:
- allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;
- allorché, dopo che l’opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli artt. 139 e 141;
- allorché, dopo una prima rappresentazione o esecuzione, l’opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, se si tratta di altra composizione.
Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.
L’art. 36 si occupa di regolare alcuni caso previsti all’articolo precedente. Nel caso previsto dal n. 1 l’autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità senza pregiudizio dell’eventuale azione di danni a carico del compositore (primo comma).
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell’azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull’opera già musicata rimane fermo, ma l’opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori(secondo comma).
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all’autore della parte coreografica o pantomimica, e, nelle riviste musicali, all’autore della parte letteraria (art. 37, primo comma).
Lo Studio Legale Dandi fornisce assistenza legale in Diritto d'autore. Dai un'occhiata ai nostri servizi oppure contattaci!